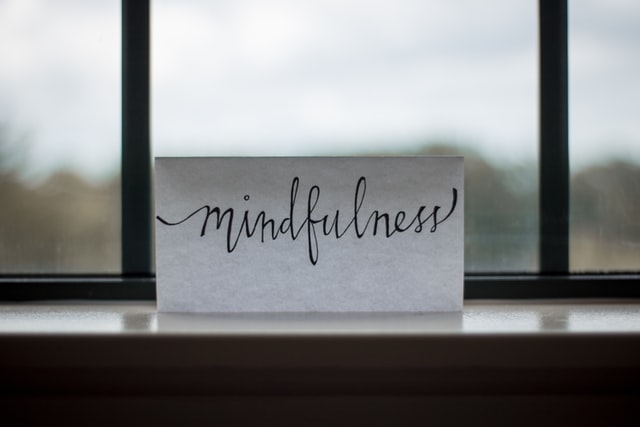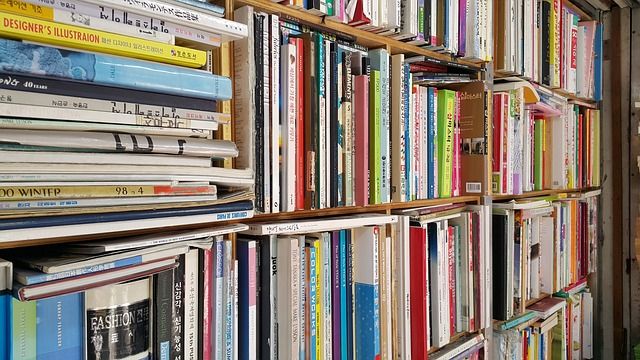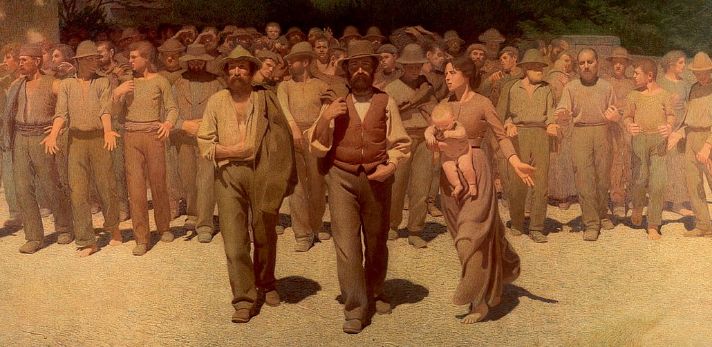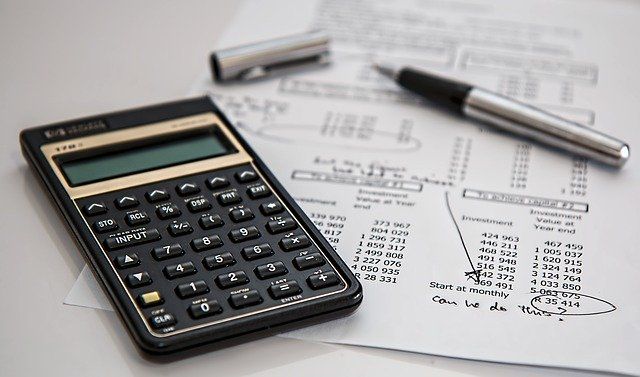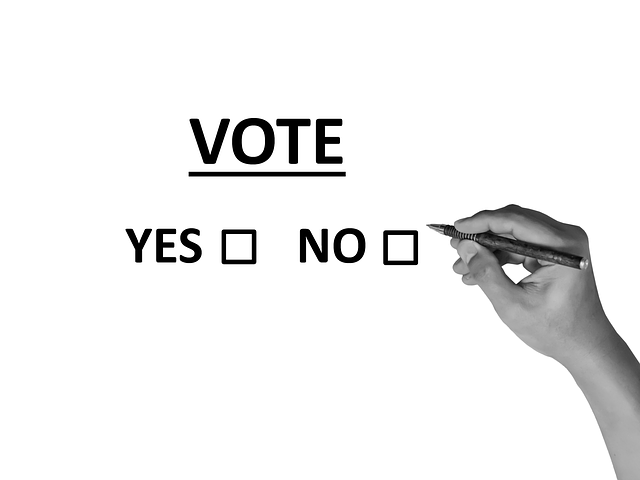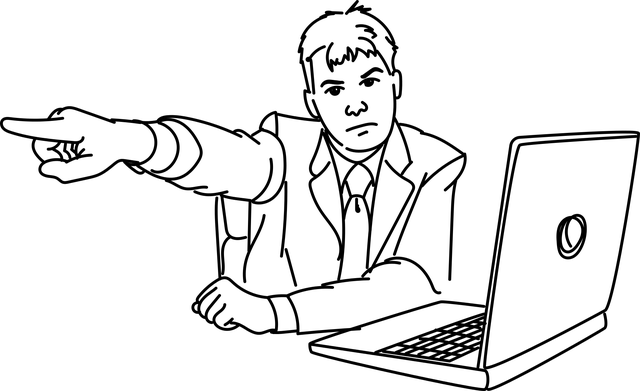La giuria del Festival del cinema di Berlino 2016 ha voluto conferire quest’anno il primo premio, l’Orso d’oro, a un documentario italiano, “Fuocoammare”, del regista Gianfranco Rosi. L’opera cinematografica ritrae storie di migranti che ogni anno giungono a bordo di barconi sulle coste dell’isola di Lampedusa e ritrae soprattutto storie di lampedusani che si attivano per dare soccorso e accoglienza umana a queste persone venute dal mare.
Il documentario mostra la quotidianità di un fenomeno, quello delle migrazioni dall’Africa e dall’Asia all’Europa, che, a partire dalla sua comparsa in forma massiccia negli anni ’80, è divenuto indubbiamente un fenomeno stabile e strutturale. Un fenomeno, dunque, che è divenuto per varie ragioni parte integrante degli equilibri di geografia umana del continente europeo: ignorarlo è impossibile, ricondurlo a semplice emergenza momentanea porta invece ad assumere misure politiche insufficienti e inadatte. Gli Stati europei si stanno dimostrando incapaci di far fronte ai flussi migratori, mettendo in campo politiche divisive, contingenti e insostenibili, quando non adottando strategie populistiche volte a mantenere momentanei consensi: che senso ha parlare di affondamenti di barconi, respingimenti o chiusura di confini come mezzi per fermare la massa umana che regolarmente si porta ai cancelli d’Europa? Pare quasi di voler così fermare un corso d’acqua con le mani.
Grandi migrazioni hanno sempre caratterizzato la storia umana; e quella in atto nel Mediterraneo non è nemmeno la più ingente riguardo i suoi numeri.
Guidati dal sogno di una vita migliore, nordafricani si imbarcano periodicamente per fare fortuna in Europa, assieme a uomini provenienti dall’Africa sub-sahariana che fuggono da guerre, fame e persecuzioni politiche; gli spostamenti umani hanno subìto variazioni con gli eventi politici: nel periodo della Primavera Araba (2011) un numero crescente di magrebini e mediorientali hanno cercato rifugio in Europa; negli ultimi mesi i flussi verso l’Europa sono aumentati in maniera vertiginosa con gli esiti della crisi siriana (iniziata più di 5 anni fa) e di quella irachena: in fuga da bombardamenti e massacri, enormi gruppi umani si sono riversati nelle nazioni confinanti come Libano e Turchia per poi intraprendere spesso un arduo percorso verso le nazioni europee.
Eppure realtà sociali come quelle europee, che hanno da secoli posto a fondamento del vivere comune il rispetto della dignità dei singoli e della loro personale ricerca di libertà e autorealizzazione (almeno nella teoria), si mostrano indifferenti alle difficoltà delle traversate nei loro mari e al numero immane di naufragi, che hanno reso i fondali mediterranei un immenso cimitero sommerso. Il fondatore della civiltà romana, base di gran parte del patrimonio culturale europeo, non fu forse il migrante Enea? Perché culture sorte negli scambi tra le coste mediterranee dimenticano i doveri di solidarietà delle leggi del mare?
Se il flusso umano dal “Sud del mondo” ai Paesi più ricchi (non solo dall’Africa all’Europa, ma anche dal Messico agli Usa, dall’Africa orientale alla Penisola araba, dal Sud-Est asiatico all’Australia) non può essere fermato, può però essere gestito. Ed è fisiologico che gli Stati intervengano con politiche migratorie di gestione per assicurare che numerosi ingressi in un breve lasso di tempo non sconvolgano gli equilibri sociali e produttivi, e i servizi essenziali e standard di vita equivalenti siano sempre assicurati a ogni cittadino del Paese indipendentemente dalla provenienza. Gli Stati, anche per ragioni di sicurezza, devono favorire l’immigrazione legale nel proprio Paese contrastando le condizioni che portano a ingressi senza documenti (contrasto per cui la criminalizzazione e la demonizzazione della clandestinità sono scarsamente producenti), innanzitutto per assicurare al migrante la fruizione dei propri diritti. E invece la gestione migratoria viene spesso utilizzata come mezzo di propaganda nazionalistica, come affare economico, come alibi per le manchevolezze dei governanti, come applicazione di strumenti coercitivi.
L’immigrazione rappresenta un’importante risorsa economica per i Paesi interessati: non c’è solo il discorso (piuttosto utilitaristico e non troppo umano) per cui gli immigrati si adattano a intraprendere lavori che i locali rifiutano, ma in generale posso dare uno sviluppo complessivo agli apparati produttivi; se posti nelle giuste condizioni, poi, rappresentano una nuova risorsa di lavoro: i migranti portano con sé nuove e diverse necessità, che aprono la possibilità di nuovi servizi da offrire e quindi di nuovi impieghi per i locali.
Il tutto, a patto che la gestione sia operata in maniera idonea. E invece il Vecchio Continente sembra inadeguato ad affrontare una sfida che in ogni caso gli si sta proponendo.
Gli Stati nazionali, per non perdere consensi elettorali, si rifiutano di prendere parte a programmi di distribuzione dei profughi (in sé la distribuzione è uno strumento criticabile, trattando le persone alla stregua di merci da allocare, ma è certo preferibile a concentrazioni in ghetti periferici negli Stati in cui sono approdati); le nazioni europee offrono opportunità solo a chi fugge da conflitti, chiudendo le porte ai “migranti economici”, come se fuggire da fame e disoccupazione non rendesse degni di accoglienza.
Nelle riunioni dei vertici europei si adottano misure emergenziali e non strutturali; le revisioni delle inadatte politiche sono state attuate sempre a seguito di fatti tragici, come il naufragio del 3 ottobre 2013 vicino le coste di Lampedusa (costato 366 morti e una ventina di dispersi) e quello del 18 aprile 2015 nel Canale di Sicilia (in cui i dispersi furono tra i 700 e i 900). E proprio per quanto riguarda le vite di chi solca il Mediterraneo su barconi, ha rappresentato un regresso il passaggio nel novembre 2014 dall’operazione italiana Mare Nostrum, iniziata nel 2013 e volta al salvataggio di migranti in difficoltà (oltre al contrasto al traffico di migranti), all’operazione europea Triton, che ha un finanziamento pari a un terzo di quello di Mare Nostrum, agisce solo fino a 30 chilometri nelle acque internazionali dal confine italiano (solo dopo il naufragio del 2015 l’area di intervento è stata ampliata) e si occupa principalmente di controllo della frontiera e non di soccorso.
A Lampedusa i centri di accoglienza dei migranti risultano continuamente colmi oltre le loro possibilità, mentre il personale medico e di assistenza è troppo esiguo per fronteggiare i numeri che gli si presentano davanti. In Italia, procedure lente rendono il soggiorno nei centri una vera e propria detenzione, mentre non di rado vengono accertati casi di espulsioni illegali anche di minori.
È vero che l’Italia si trova a essere geograficamente esposta ai flussi migratori ed è lasciata sola dalle concertazioni di carattere europeo, che hanno a lungo lasciato nazioni come Italia e Grecia a farsi carico di tutti i rifugiati in nome del Regolamento di Dublino (convenzione rinnovata nel 2013 per la quale il primo Paese europeo in cui il migrante sia registrato è quello a cui egli dovrà fare richiesta d’asilo); ma ciò non esime l’Italia dalle sue responsabilità nell’aver dimostrato gravi mancanze nell’accoglienza e nella gestione di richieste d’asilo.
A Calais, nel Nord della Francia, migliaia di profughi si sono visti rifiutare la possibilità di raggiungere il Regno Unito per chiedere qui asilo e si sono assiepati a vivere, assieme a migranti economici, in un enorme campo (la cosiddetta “giungla”), dove la qualità dell’acqua è dubbia, le condizioni igieniche precarie e i ripari sono di legno e teli di plastica in mezzo al fango.
Il 25 febbraio 2016 il Tribunale di Lille ha deciso lo sgombero progressivo del campo e l’area meridionale della tendopoli (abitata da circa 3400 persone) è in corso di svuotamento: i migranti saranno alloggiati in un campo di container riscaldati (14 persone per ogni container, senza intimità, con docce comuni del campo realizzate solo su pressione di organizzazioni umanitarie); una soluzione più umana ma non ancora adeguata.
A Calais i profughi rischiano spesso la vita per cercare di oltrepassare la Manica, come fanno gli africani che muoiono sul filo spinato per giungere nelle terre spagnole in Africa, come fanno i migranti che muoiono asfissiati nei camion in cui sono stipati per passare le frontiere europee.
Sull’isola greca di Lesbo si riversano i tantissimi profughi (soprattutto siriani e iracheni, ma anche molti afghani; nel febbraio 2016 dagli 800 ai 1000 al giorno) che dalla Turchia cercano di passare in Europa dopo aver attraversato un pericoloso tratto di mare.
L’isola è sovraffollata e la Grecia, già provata dalla crisi economica, vede rinvigorirsi l’estrema destra, mentre sono molti i naufragi e le morti in mare.
Eppure, ai primi del settembre 2015, un’immagine ha destato attenzione: il piccolo corpo di un bambino curdo di 3 anni, Aylan Kurdi, annegato in una traversata e immortalato mentre giaceva sulla spiaggia turca di Bodrum. Se le molte immagini scattate negli ultimi anni di piccoli migranti africani annegati non hanno sortito grandi effetti (triste a dirsi), questa foto ha scosso l’opinione pubblica occidentale, in virtù del fatto che il bambino fosse bianco e vestito in abiti di foggia europea, quindi facilmente identificabile in un bambino europeo.
Questa triste morte ha prodotto pressioni sui leader europei (il premier britannico David Cameron ha aperto le porte a un maggior numero di siriani sulla scia della notizia) e ha rafforzato il consenso attorno alla decisione presa nella fine dell’agosto 2015 dalla cancelliera tedesca Angela Merkel di offrire asilo in Germania a tutti i profughi provenienti dalla Siria (indipendentemente dalla Convenzione di Dublino). Per quanto la decisione di accogliere in maniera più semplice avrebbe potuto riguardare anche profughi di altri conflitti, la Germania ha comunque scelto di dare grande prova di solidarietà e di portare le altre nazioni europee ad adottare la stessa attenzione alla questione dei rifugiati.
Ci sono stati episodi di intolleranza da parte di gruppi neonazisti (come quelli che hanno dato alle fiamme centri di accoglienza o quelli che, assieme ad alcuni residenti, il 23 febbraio 2016 hanno vigliaccamente circondato un bus di rifugiati tra cui diversi bambini impauriti), ma intanto una parte considerevole del mondo imprenditoriale e in generale della società tedesca si è mobilitata nell’offrire opportunità per i profughi e nel realizzare progetti inclusivi a lungo termine, dimostrando come una volontà diffusa possa dare grandi vantaggi a tutte le parti in causa. E molti economisti prevedono sul lungo termine enormi benefici per l’economia tedesca, che potrebbe andare incontro a un nuovo boom economico.
Ma intanto soluzioni importanti per le traversate tra Turchia e Grecia non sono ancora state adottate: sono stati aperti alcuni corridoi umanitari (spesso a carico di gruppi religiosi e associazioni umanitarie) che consentono a chi fugge dai conflitti mediorientali di raggiungere in aereo l’Europa per chiedere accoglienza; ma sono troppo pochi e tutt’oggi bambini come Aylan Kurdi annegano nel mar Egeo.
In realtà l’immigrazione mette a nudo le contraddizioni e i punti deboli delle nostre società: in società dinamiche, inclusive e giuste, nuova forza lavoro e nuove menti per l’innovazione rappresentano una risorsa da incanalare nei giusti settori e da valorizzare per la crescita complessiva della società, che tutta va a raccoglierne i frutti; ma le società europee appaiono sempre meno così.
Il potere può quindi puntare il dito sul migrante e accusarlo di responsabilità per un’economia stagnante e una società immobile, in realtà messe in evidenza anche dalla presenza del migrante, anziché lavorare a porvi rimedio, magari creando inedite possibilità di sviluppo, investendo in innovazione, fornendo pari accesso alle possibilità lavorative.
I movimenti politici razzisti e xenofobici, raccontando di una società organica e solida minacciata dall’esterno dall’immigrazione, fungono da stampella ai poteri, nascondendo i conflitti e i divari che attraversano la società, eludendo il problema delle diseguaglianze e degli iniqui sistemi di potere per lanciare invettive contro lo straniero.
Una caratteristica intrinseca della condizione del migrante è la vulnerabilità: vaga spesso senza riferimenti e con scarsi mezzi, privo del supporto di una comunità; non è un caso che il bacino da cui attingono le attuali forme di schiavitù umana siano i flussi migratori. La loro vulnerabilità fa sì che gli Stati possano mettere in atto, senza reazioni dell’opinione pubblica, forme di oppressione e di disumanità, controllando i gruppi di migranti senza considerazione per le loro necessità, assiepandoli in centri di identificazione in numeri immensi e con scarsa igiene oppure bloccandoli con barriere a vivere all’aperto in difficili condizioni, usando repressioni poliziesche con lacrimogeni e manganelli: attuando, insomma, politiche irrispettose dei diritti umani in cui le persone, disumanizzate, divengono semplice strumento del potere.
Della vulnerabilità dei migranti approfittano anche le organizzazioni criminali che vedono in persone spesso disperate e disorientate manodopera a basso costo; privi delle sicurezze assicurate dallo stato sociale per il quale sono inesistenti, vengono usati per lavori pesanti, furti e traffico di droga.
Relegati ai margini di società immobili, assoldati in lavori degradanti o fuori legge, i migranti sono condannati in massa a vite di stenti, violenza e degradazione.
L’ambiente di degrado in cui i migranti sono costretti dà luogo a espressioni di brutalità; la necessità fa mostrare i denti e la legge del “mors tua vita mea” prende spesso piede: scene come gli assalti dei profughi ai treni per l’Europa centrale in cui ragazzini venivano spintonati giù dagli uomini più possenti, come l’efferatezza di delitti maturati in gruppi di immigrati (verso altri immigrati o verso residenti) durante rapine, affari o semplici liti, fatti che divengono strumento prediletto per la propaganda razzista e xenofobica. La condizione umana e sociale non giustifica atti cruenti, ma è un fatto che tali atti aumentino in ambienti degradati e caratterizzati da miseria e stato di necessità.
In più l’incontro tra persone cresciute in realtà differenti è raramente semplice e indolore; il confronto col diverso, con l'”altro”, porta a mettere in discussione se stessi: e ci si può aprire al confronto con la diversità o chiudersi in difesa di una presunta identità, di appartenenze a gruppi esclusivi senza vedere le capacità fluide e inclusive delle identità personali e sociali. Il rapporto con il “diverso” è vera fonte di arricchimento. La convivenza può essere difficile da raggiungere, ma di certo non impossibile.
La società svedese ha sempre mostrato grandi capacità di apertura e rappresenta il primo Paese europea per presenza straniera in rapporto alla superficie; tuttavia negli ultimi anni ha mostrato delle chiusure, poiché l’impatto dell’immigrazione ha talvolta dato effetti negativi: gli stranieri che vivono di elemosina e accattonaggio stonano nel contesto ordinato svedese e in un Paese in cui la cronaca nera è quasi inesistente i pochi fatti di sangue degli ultimi anni hanno visto principalmente stranieri di varie nazionalità esserne protagonisti. Ciò ha spostato a destra parte dell’elettorato svedese, ma concezioni razziste rimangono minoritarie: un serio dibattito politico sul governo dell’immigrazione e l’efficacia dell’inclusione di massima parte degli immigrati affievoliscono le spinte xenofobiche.
Nella notte di Capodanno 2016, in diverse città tedesche come Colonia e Amburgo, gruppi organizzati di giovani immigrati hanno attuato in massa molestie e stupri, in un’esaltazione di maschilismo e disprezzo: un episodio inaccettabile come questo non può certo fare da pretesto per irrealistiche e populistiche campagne contro lo straniero, ma pone questioni su come sia possibile favorire una reale inclusione e diffondere con forza voci che contrastino visioni maschiliste (che certamente non mancano neanche nella cultura europea, pur con forme diverse).
Le immagini dei profughi mediorientali in cammino attraverso il continente europeo hanno impaurito parte dell’opinione pubblica europea: a sconvolgere è questa percezione di una massa umana che si muove con apparente irrazionalità, giunta a rompere le nostre certezze ordinate, presentata come una specie di minacciosa orda barbarica. E invece si può guardare in termini umani a queste persone pronte ad attraversare boschi e guadare torrenti per la meta sognata: i tedeschi che nel settembre 2015 hanno accolto i profughi siriani alla stazione di Monaco hanno dimostrato che è possibile pensare ai flussi migratori con diverso atteggiamento; quello stesso che hanno le forze impegnate nei soccorsi in mare, i centri culturali che operano per l’integrazione, gli attivisti nei centri di identificazione e nei campi per rifugiati, il personale sanitario alle frontiere, i volontari che lavorano per l’accoglienza.
Le strade ci sono: pratiche virtuose di accoglienza e integrazione fioriscono nonostante il disinteresse delle autorità e sarebbe anzi necessario che gli Stati si impegnassero a sperimentarle su più ampia scala.
I migranti hanno una forza, quella di chi ha patito e ha addosso poche cose tra cui di certo la speranza, la forza di chi ha sentito il dolore del distacco dalla propria terra, quella di chi vede alle sue spalle la morte e sa che davanti ci può essere solo la vita, per guadagnarsi la quale nulla può essere insormontabile (non le barriere di filo spinato innalzate da macedoni, sloveni e ungheresi, non l’oscurità dei mari agitati, non marce chilometriche nei Balcani e notti all’addiaccio da affrontare); e poi, provenendo da Paesi in cui l’età media della popolazione è bassissima, sono soprattutto ragazzi ad affacciarsi sull’Europa invecchiata; e hanno, come tutti i giovani, una irrefrenabile voglia di vivere.
Sta ora al continente europeo e ai suoi leader (ma ancor più ai loro elettori) la scelta: guardare con occhio fraterno chi fugge da condizioni che anche l’Europa ha contribuito a determinare, far fruttare le energie che accorrono in cerca di opportunità, includere i nuovi arrivati in un cammino comune e costruire realtà nuove e aperte; oppure chiudersi nella conservazione di un esistente che è già passato, proseguire tra odii e disagio sociale, innalzare muri riesumando stagioni di disumanità e assistere all’asfissia del nostro sistema produttivo e sociale.